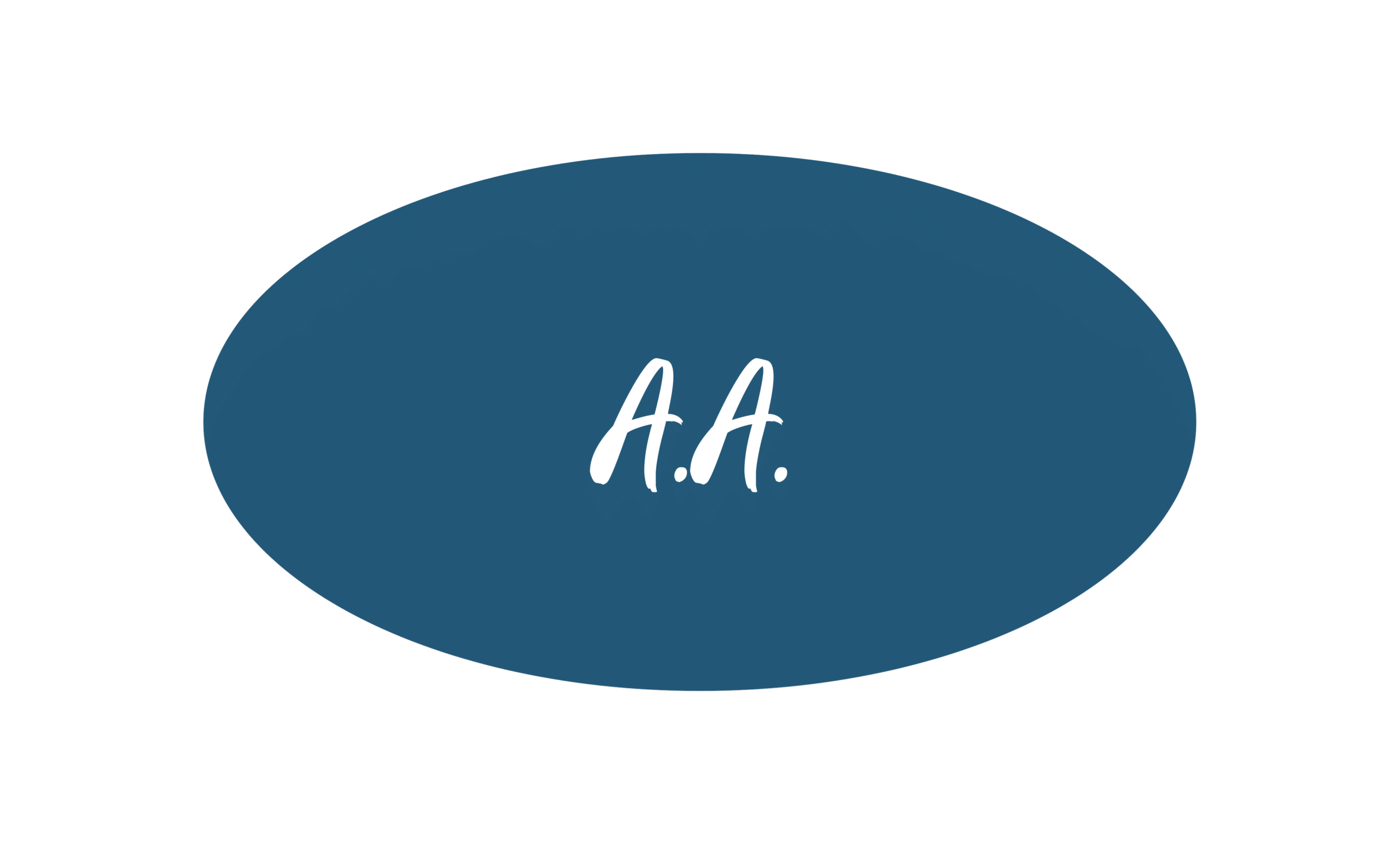Burry diventa una notizia anche quando non lo è! Prima ancora che i mercati si mettessero a ballare fra IA lunari, bond in rimonta e trader in terapia, il protagonista delle ultime settimane è tornato a essere lui: Michael Burry, l’uomo che ha previsto la crisi dei subprime e che ormai i media trasformano in breaking news ogni volta che starnutisce. Due titoli hanno dominato la narrativa:
- “Burry shorta NVIDIA e Palantir: la bolla AI sta per esplodere?”
- “Burry chiude il fondo: fine di un’era!”
Peccato che entrambe le storie siano più clickbait che verità.
Partiamo dallo short su Nvidia e Palantir: è circolato ovunque come la nuova profezia apocalittica. Il problema? Non sappiamo né le dimensioni reali, né la strategia, né se si trattasse di uno short “puro” oppure — molto più plausibilmente — di coperture tattiche legate a posizioni long altrove. Il famigerato 13F, infatti, non dà queste informazioni: non dice il prezzo, non dice la durata, non dice il contesto. Ma tant’è: per i social, “Burry shorta l’AI” funziona meglio di “Burry bilancia il portafoglio”.
Poi c’è la seconda bomba mediatica: “Michael Burry chiude Scion Asset Management!”
Ha fatto il giro del mondo in poche ore, con toni funebri e analisi drammatiche. La realtà? Molto più banale: con ogni probabilità Scion si sta semplicemente trasformando in un family office, una mossa sempre più comune tra investitori ad altissimo patrimonio per un motivo semplice: un family office non deve più rendere pubbliche le proprie posizioni tramite i 13F trimestrali.
Tradotto: meno obblighi di disclosure, più privacy, meno speculazioni. Non un addio ai mercati, ma un cambio di struttura — e per uno come Burry, che odia i riflettori, praticamente un upgrade spirituale.
Il punto è sempre lo stesso: ogni movimento di Burry viene teatralizzato come se stessimo assistendo alla recensione del mondo versione The Big Short 2 – La Vendetta. Ma il mercato reale è molto meno cinematografico: le strategie sono complesse, multilivello, e raramente si prestano al sensazionalismo da tweet.
Vendite tech e rotazione tattica: quando l’IA è benzina per il rally… e anche tappo per la bomba
Venerdì scorso è stato come vedere la Ferrari in pista… con il freno a mano inserito. Un sell-off che ha colpito i mercati USA e si è esteso globalmente è finito contro una delle forze più potenti della corsa pluriennale americana: le grandi tech. Dopo l’apertura della campanella a Wall Street, titoli come NVIDIA Corporation, Oracle Corporation e altri protagonisti del boom dell’intelligenza artificiale sono scivolati tanto da accendere il semaforo verde per i “dip-buyers” (quelli che comprano nei ribassi). Poi, in un colpo da dramaturgia finanziaria, i mercati hanno recuperato quasi tutto: l’indice S&P 500 ha chiuso la settimana sostanzialmente piatto, mentre il Nasdaq Composite ha registrato un calo di circa -1,9% giovedì, il suo peggior andamento settimanale da aprile.
Le cause? Il mercato si sta interrogando se lo sforzo monumentale delle big tech — tra chip, data centre, infrastrutture IA — produrrà davvero ritorni all’altezza delle attese. In parallelo, la mancanza di dati federali ottenuti durante il blocco del governo USA ha lasciato gli investitori con una sorta di mappa senza coordinate: “che rotta prendiamo?”
Ecco qualche numero da tenere a mente: negli ultimi mesi, i titoli tecnologici legati all’IA sono cresciuti in media +22% dall’inizio dell’anno, ma nel loro picco hanno registrato cadute del -5,6% durante la recente battuta d’arresto. La rotazione verso settori più difensivi come healthcare, materiali ed energia — che hanno guidato la settimana nell’S&P 500 — suggerisce che il motore IA possa aver bisogno di cambiare marcia.
Visto che il rally era alimentato da un mix di fiducia e “fomo tech”, alcuni investitori si stanno chiedendo se la fase “dip-buy” (comprare nei cali) sia già logorata. Come ha detto David Bahnsen della Bahnsen Group: «È successo più volte, ma a un certo punto i compratori non tornano». E in effetti: la resa del 10-15% su alcune posizioni tech sta dando da pensare.
Quindi se fino a ieri la narrativa era “l’IA porta al prossimo livello”, oggi è più “ok, ma quanto paghiamo per il pass?” Il rally c’è, ma il tappo può saltare. E chi pensa al portafoglio non può più ignorare che la leva tech è vivace… ma anche fragile.
Bondlandia rinasce: quando anche i gestori obbligazionari tornano a sorridere (dopo anni di terapia)
Quasi tutto, ultimamente, si sta allineando a favore delle obbligazioni — un evento raro quanto un volo Alitalia in orario. La Federal Reserve ha già tagliato i tassi due volte nel 2025, il mercato del lavoro rallenta quel tanto che basta per tenere accesa la speranza di nuovi tagli (ma non abbastanza da gridare “recessione in arrivo”), e l’inflazione continua a moderarsi nonostante i timori che i dazi di Trump potessero far decollare i prezzi come un Falcon 9.
Risultato? Il Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index — il benchmark del reddito fisso statunitense — ha messo a segno un +6,7% da inizio anno, proiettandosi verso il miglior risultato dal 2020. Non male per un asset class che nel 2022 era stata “presa a schiaffi dalla storia”, con il peggior drawdown in oltre quarant’anni. Dopo un +5,5% nel 2023 e un 2024 praticamente in folle, il 2025 sembra finalmente l’anno in cui i bond tornano sexy.
E i gestori obbligazionari, dopo anni di isolamento sociale, vengono persino invitati di nuovo ai meeting coi clienti: «Quest’anno è decisamente più divertente», scherza (ma non troppo) Cal Spranger di Badgley Phelps. Del resto, i rendimenti, pur in calo, restano molto superiori ai livelli “anemici” del decennio post-2008. Non a caso molti investitori vogliono bloccarli finché si può.
Il decennale USA è sceso di quasi 50 punti base nel 2025, attestandosi al 4,147%, mentre le previsioni sul taglio tassi di dicembre oscillano come un pendolo di Newton: dal 67% di probabilità la settimana scorsa al 46% attuale. La Fed, infatti, non parla più come una colomba: Powell ha dichiarato che il taglio a dicembre è «tutto fuorché scontato». Tradotto: smettete di tirare a indovinare.
Eppure non è tutto rosso e fiori. Gli spread sull’investment grade sono crollati a 0,72 punti percentuali a settembre, minimo dal 1997, e anche con la risalita a 0,83, siamo ancora in zona “non ci stanno pagando per il rischio”. Nel frattempo, il deficit federale resta un macigno da 1.800 miliardi di dollari, più o meno quanto l’anno scorso: un dettaglio che, prima o poi, potrebbe presentare il conto.
Ma per ora, il mercato obbligazionario vive la sua piccola età dell’oro: tassi in calo, inflazione che frena, dati macro che non spaventano e un’amministrazione che — tra una tariffa e l’altra — fa attenzione a non far infuriare i “bond vigilantes”. E quando perfino i gestori di reddito fisso iniziano a sorridere, è un segnale che la musica sta cambiando… o che siamo vicini alla fine del brano.
Dentro i “pod shop”: dove si gestiscono miliardi, si dorme poco e lo psicologo è il vero alpha generator
Nel mondo scintillante — e leggermente paranoico — degli hedge fund multimanager, la competizione non è solo verso il mercato: è interna, quotidiana e spesso brutale. Ed è qui che entra in scena Dave Popple, 59 anni, psicologo di professione e risk manager dell’anima. Le sue giornate scorrono tra trader con dark circles permanenti, ansie da drawdown e punizioni auto-inflitte degne di un monaco tibetano: uno si era proibito il sushi (il suo piatto preferito) dopo tre giorni di perdite. Altro che gestione del rischio.
I “pod shop” — Citadel, Millennium, Point72 — sono ormai i Leviatani di Wall Street: strutture fatte di mini-team autonomi, ognuno con il proprio P&L, giudicati settimanalmente, quando non giornalmente. Bastano –5% di performance per vedersi ridotto il capitale in gestione; due o tre mesi storti e ti viene gentilmente indicata l’uscita. È capitalismo darwiniano nella sua forma più pura, alimentato da volatilità, FOMO e ansie da bolla AI.
In un contesto simile non stupisce che molti finiscano a “spiralare”: insonnia, autocritica distruttiva, burnout. Popple li rimette in carreggiata separando la performance dal valore personale. La sua domanda preferita è una lama affilata: «Che consiglio daresti a un tuo analista nella tua stessa situazione?» La risposta è quasi sempre pietosa e ragionevole — che, ovviamente, nessuno applica a se stesso.
Il coaching psicologico dei manager non è certo nuovo: da Julian Robertson a Steve Cohen, passando per i famosi profili clinici che hanno ispirato Wendy Rhoades in Billions, Wall Street ha sempre avuto un debole per la psicoanalisi — purché aumenti lo Sharpe ratio. Ma l’ascesa dei pod shop ha amplificato tutto: team piccoli, competizione interna feroce e zero trasparenza verso i superiori (“non si ammette debolezza, perché c’è sempre uno che fa meglio di te”).
Popple cerca soprattutto la combinazione vincente: attenzione selettiva che “perde un po’ d’acqua” — utile per cogliere micro-segnali — unita a disciplina sovrumana. I migliori non sono materialisti né narcisisti: sono competitivi per il punteggio, non per il lusso. Sbagliano il 50% delle volte, eppure sono i più ossessivi nel voler migliorare. E, sorpresa delle sorprese: molti hanno vite private sorprendentemente solide. A differenza di altri settori ad alto stress, i top trader allocano tempo e risorse nel mantenere relazioni familiari sane. Una forma di diversificazione che, probabilmente, sottoscriverebbe anche Ray Dalio.
Nei pod shop la finanza è scienza, arte e psichiatria insieme. E forse l’alpha non nasce solo da modelli sofisticati, ma dal semplice tentativo di tenersi in piedi mentre si corre una maratona — spesso letteralmente, dato che metà dei candidati di Popple è composta da runner compulsivi.
AI to the Moon: la bolla tecnologica guarda lo spazio e i miliardari parlano come Doc Brown
Se pensavi che l’hype sull’intelligenza artificiale avesse raggiunto il picco, preparati: ora guarda letteralmente alla Luna. Mentre i mercati discutono se siamo o no in una bolla, i miliardari più potenti del pianeta – Bezos, Musk, Pichai – stanno parlando seriamente di costruire data center spaziali per far girare modelli IA tra stelle, polveri lunari e zero regolatori che protestano (“in space no one can hear the Nimbys scream”, come dicono loro).
Jeff Bezos definisce la Luna «un regalo dell’universo», una frase che suona più da film Disney che da conferenza tech, ma che ha una logica: nello spazio il Sole brilla sempre, senza nuvole, senza notte e senza attivisti ai comitati urbanistici. Elon Musk, dal canto suo, rilancia come sempre in modalità livello boss: la sua SpaceX e la sua xAI hanno già iniziato a usare turbine a gas per alimentare supercomputer in attesa che la rete elettrica si rafforzi. E ora annuncia che in orbita i pannelli solari potrebbero generare 100 gigawatt l’anno – un quarto dei consumi elettrici medi degli Stati Uniti. Per contestualizzare: in Ritorno al Futuro servivano 1,21 gigawatt per viaggiare nel tempo. Oggi 1 GW è la metà della potenza di Hoover Dam. Insomma: altro che DeLorean.
Secondo Phil Metzger, ex NASA e oggi professore alla University of Central Florida, i data center spaziali non sono economicamente sensati oggi… ma potrebbero diventarlo nel giro di 10-15 anni. E nel frattempo Google non resta a guardare: il Project Suncatcher prevede il lancio di due satelliti prototipo nel 2027 per testare l’addestramento in orbita. Nvidia ha già firmato una partnership con Starcloud per lavorare su server extraterrestri.
Poi, ovviamente, c’è Musk. Il visionario di SpaceX sta parlando di usare razzi per distribuire in orbita nuove generazioni di satelliti Starlink con laser ad altissima velocità, e perfino di creare una base lunare che “spari” nello spazio 100 terawatt l’anno di potenza raccolta dal Sole. Sì, terawatt. Sì, dalla Luna. Sì, l’idea è letteralmente quella di un catapulta spaziale che lancia satelliti in orbita.
Il tutto mentre, sulla Terra, il presidente Trump ha dichiarato un’emergenza energetica nazionale, con il governo che stima la necessità di aggiungere 100 GW l’anno di capacità solo per far fronte alla domanda dell’IA nei prossimi anni. OpenAI ha chiesto al governo partnership pubblico-private per accelerare. Musk, Bezos e compagnia bella hanno alzato l’asticella: se la Terra non basta, ci si espande nello spazio.
Sembra fantascienza. Ma è la stessa fantascienza che qualche anno fa faceva sorridere quando Musk insisteva che le reti elettriche sarebbero finite sotto pressione. Oggi lo dice la Casa Bianca. Domani forse installeremo pannelli solari su Marte.
Come direbbe Doc Brown: “If you put your mind to it, you can accomplish anything.”
Per ora, proviamoci almeno sulla Terra.
La colazione costa troppo: coffee shock, banana-flation e la mossa di Trump sui dazi alimentari
Se il rally dell’IA è andato sulla Luna, quello dei prezzi del supermercato resta saldamente sulla Terra — e continua a picchiare duro. A settembre, i prezzi al dettaglio del caffè macinato sono aumentati di oltre +40% su base annua, secondo il Bureau of Labor Statistics: un’impennata degna di un titolo tech nel 2020, con la differenza che qui non c’è alcun dividendo. La carne macinata segna un +11,5%, le banane +8,6% rispetto al 2024, tutti ben oltre l’inflazione generale vicino al 3%.
Per questo, venerdì, Trump ha tagliato i dazi su carne, caffè, banane e decine di altre importazioni agricole, tentando di rispondere direttamente alla sensazione — politicamente devastante — che il costo della vita sia fuori controllo. Non è un caso che la “grocery inflation” stia diventando un catalizzatore elettorale: nelle elezioni in New Jersey e Virginia, la rabbia per i prezzi del cibo ha contribuito alle recenti sconfitte repubblicane.
Il problema è strutturale. Gli USA importano la maggior parte del caffè e delle banane, e gli importatori lavorano con margini più sottili di un foglio Excel: ogni aumento tariffario viene immediatamente riversato sul consumatore. Peggio ancora, le banane non si possono nemmeno stoccare a lungo per aggirare i dazi — non sono automobili o laptop, ma merce che scade in giorni. Diversi economisti, come Troy Ludtka (SMBC Nikko), ricordano che prezzi e volatilità dipendono anche dal clima, che negli ultimi anni ha colpito duramente molte aree produttrici.
Il caso del manzo è ancora più curioso: i dazi hanno giocato un ruolo, ma il principale responsabile è la riduzione delle mandrie americane, scese ai minimi da quasi un decennio per via della siccità e dei costi di allevamento. Le importazioni avrebbero potuto compensare il calo, ma dazi fino al 50% sulle importazioni dal Brasile — grande esportatore sia di caffè sia di carne — hanno aumentato la pressione sui prezzi.
Ora, la rimozione dei dazi dovrebbe aiutare a invertire la tendenza, ma gli economisti avvertono: i prezzi “prendono l’ascensore quando salgono e le scale quando scendono”. Anche dopo un taglio delle tariffe, i supermercati ci mettono tempo a riportare i listini giù. In altre parole: l’effetto politico è immediato, quello sullo scontrino molto meno.
Morale finale? L’inflazione alimentare continua a essere uno dei principali fattori di malessere economico per la classe media — e nessun algoritmo quantistico o data center lunare potrà convincere gli elettori che una banana da 89 centesimi oggi valga davvero 1,09 dollari domani.